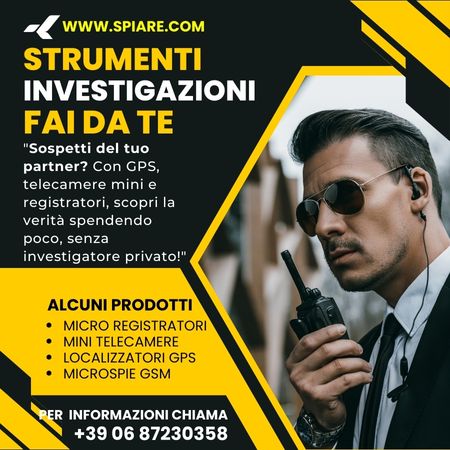Una strategia che prescrive all’Unione una profonda revisione di scelte e della propria identità per non essere esclusi dal futuro globale. L’ha tratteggiata Mario Draghi, ovvero colui che queste istituzioni le ha comunque costruite…
È la sindrome Bocca di rosa, dalla canzone di Fabrizio De André: si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Ha colpito pure Mario Draghi, che si fa censore del declino europeo avendo assai contribuito alla costruzione di quest’Europa a partire dal 1992 quando organizzò sul Royal Yacht «Britannia» la svendita delle industrie di Stato per inseguire il diktat della triade Andreatta-Carli-Ciampi, la quale invocava il vincolo esterno per un’Italia riottosa alle regole. Avverte l’ex presidente della Banca centrale europea che il continente o cambia in fretta, risolve i problemi dell’energia, fa debito comune, si arma e torna protagonista nella ricerca e nella diplomazia, o si sfalderà. I numeri messi in fila da Draghi sono impressionanti; 800 miliardi di euro all’anno d’investimenti pari al 4,7 per cento del Pil dei 27 per cogliere tre obiettivi: cercare di colmare il gap con Stati Uniti e Cina, decarbonizzare, difendersi. I soldi si trovano dal debito comune e dalle tasche degli europei tenendo presente che da qui al 2040 si perderanno in Europa due milioni di lavoratori all’anno. Dunque: aumentiamo l’immigrazione.
La forbice tra il Pil Usa e quello della Ue si è allargata dal 15 per cento d’inizio secolo al 30 per cento dello scorso anno e il reddito pro capite oltre Atlantico oggi è il doppio di quello europeo. Però a parlar male di Bruxelles si fa peccato. Lo ha ricordato Sergio Mattarella al recente Forum Ambrosetti di Cernobbio; deve aver avuto in anteprima il dossier di Draghi. Ha detto il presidente della Repubblica: l’Italia deve ridurre il debito, ma questo non è il solo parametro, l’Europa è incompleta, ma guai a sollevare dei distinguo. Le risposte che nei fatti Draghi ha incassato vanno però in direzione ostinata e contraria: il suo studio è destinato a finire in un cassetto. Ursula von der Leyen che rinvia la presentazione della sua nuova Commissione. Ci sono tensioni: difficile che una maggioranza composta da Ppe, Socialisti, Verdi e Liberali passi indenne dal Parlamento, dove i veri vincitori sono le formazioni di destra. Il caso Raffaele Fitto, il nostro ministro agli Affari europei indicato da Giorgia Meloni come prossimo commissario e vicepresidente esecutivo con delega all’Economia e al Pnrr, agita i sonni della Von der Leyen. La baronessa intende proporlo, mentre Renew, ciò che resta di Emmanuel Macron, Socialisti e Verdi non vogliono sentirne parlare. Al punto che il Pd sta studiando il da farsi, ma la segretaria Elly Schlein boccerebbe Fitto molto volentieri.
Ci sono i tedeschi con l’economia in panne e preoccupatissimi per l’avanzata dei sovranisti di destra (Afd) e di sinistra, i quali non vogliono fare debito comune, ma soprattutto sono stanchi di guerra in Ucraina. Hanno di nuovo bisogno del gas russo, tentennano sull’aiuto a Volodymyr Zelensky, si mettono di traverso sui dazi alla Cina. Il cancelliere Scholz chiude le frontiere per bloccare i migranti, Viktor Orbán addirittura vuole spedire chi arriva in Ungheria direttamente a Bruxelles e chiede di trattare con Mosca. Su economia, migranti, politica estera viene da chiedersi: se questa è Europa… Si parla molto del debito italiano, pochissimi però ricordano che si è accumulato per pagare la spesa per interessi a partire dalla lettera del 12 febbraio 1981 quando Carlo Azeglio Ciampi, allora governatore della Banca d’Italia, e Beniamino Andretta ministro del Tesoro decisero il divorzio tra palazzo Koch e via XX Settembre. Tra il 1980 e il 1994 il debito crebbe dal 57,7 per cento sul Pil nel 1980 al 124,3 nel ’94; la spesa per interessi passò dall’8 per cento del Pil nel 1984 all’11,4 dieci anni dopo, la maggiore d’Europa con una punta nel 1993 del 13 per cento a petto del 4,4 in quella che si apprestava a essere la zona euro. Fu allora che Mario Draghi lanciò l’idea di svendere per inseguire l’euro. Il secondo enorme stock si è sostanziato con l’entrata in vigore dell’euro e le regole di Maastricht. Quelle che la scorsa settimana Draghi ha criticato presentando il suo rapporto sulla competitività che è già lettera morta e nulla ha di rivoluzionario. È l’espansione in circa 400 pagine di un articolo che aveva scritto per il quotidiano Financial Times nell’aprile del 2020 esortando l’Ue a fare qualcosa perché l’economia congelata dal Covid riprendesse. Anche da quell’esortazione scaturì il Next Generation Ue che oggi traduciamo in Pnrr, che non è debito comune: va ripagato! Draghi ha riproposto quello schema con toni ancora più severi. O l’Europa cresce o si avvia a un’agonia.
L’ex presidente del Consiglio vuole un «piano Marshall» – doppio nelle proporzioni rispetto all’originale – da investire in tecnologia, difesa, recupero di produttività, sostenibilità. Per farlo serve debito comune e attaccare il risparmio privato: 1.200 miliardi di euro all’anno. È perciò necessaria una riforma radicale in Europa: basta decisioni all’unanimità e in sottofondo (è da sempre un tratto distintivo del Draghi-pensiero) basta anche con questo eccesso di autodeterminazione: gli Stati devono cedere sovranità alla struttura tecnocratica di una Commissione che deve essere riformata e rafforzata. Queste le parole di Draghi: «Se non vogliono continuare ad arretrare in un contesto internazionale in rapida evoluzione, la Ue e i suoi Stati membri devono agire e smetterla di procrastinare, di rinviare le decisioni che devono essere prese, nell’illusione di preservare il consenso degli elettori. La Ue deve agire per riformarsi, se non vuole spegnersi in una lenta agonia».
Ovviamente le scelte per l’ambiente sono indiscutibili e il tema centrale è: meno regole e più soldi. Uno studio dell’Università del Nevada ha messo a confronto la strategia green di Ue e Usa ed è arrivato a questa conclusione: l’Europa ha fatto solo regolamenti, gli Stati Uniti cinque norme e 730 miliardi di dollari d’investimenti. Nel rapporto sulla competitività chiesto dalla Von der Leyen, Draghi ha tentato una riedizione del suo imperativo Whatever it takes, ma non gli è andata benissimo. Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha replicato a stretto giro: «Il prestito congiunto dell’Ue non risolverà alcun problema strutturale. Più debito pubblico costa interessi, ma non crea necessariamente più crescita». Già: quando era alla Bce, Draghi non suscitava entusiasmi in Germania e in tedesco «debito» e «colpa» suona assai simile: schuld/schulden… Dalla Francia arriva un’apertura, ma la rampogna dell’ex presidente della Bce è durata lo spazio di un mattino. L’Europa non è in grado di emendarsi perché non ha mai completato la sua unione e il «censore» dovrebbe meditare sul detto latino: medice, cura te ipsum. Perché Draghi che invoca debito comune – come peraltro fa Piero Cipollone, membro italiano del board della Bce convinto che un titolo garantito dall’Ue vada a ruba e abbia la «tripla A» – è la stessa persona che il 5 agosto 2011, entrando in Bce, firmò con Jean-Claude Trichet la lettera di sfratto a Silvio Berlusconi mentre Giulio Tremonti, ministro dell’Economia, invocava gli Eurobond. Difese l’impatto rigorista dei governi tecnici e senza consenso che ha portato il debito/Pil dal 126 per cento con Mario Monti al 149 per cento con lo stesso Draghi. Oggi il nuovo patto di stabilità è ancora la camicia di forza.
La Germania – produzione industriale crollata del 2,4 per cento – non intende fare sconti. Lo sa anche l’attuale presidedente Bce Christine Lagarde che deve tagliare i tassi a tappe forzate per far marciare l’economia, soprattutto se lo farà anche la Federal reserve americana. Ma lo fa con un primo timido passo (-0,25). E infatti Isabel Schnabel – è la «badante» della Lagarde in Bce per conto della Bundesbank – fa sapere: piano con i tagli. Anni fa – plaudente Draghi – Angela Merkel proclamò: ciò che è buono per la Germania lo è per l’Europa. Ora la Francia con Michel Barnier, appena imposto da Macron quale premier, non sa come fare la sua finanziaria. Gli è esploso il debito (oltre il 100 per cento del Pil), ha i redditi in caduta, la produzione giù di mezzo punto. L’Europa in preda a due debolezze è la stessa del dumping fiscale fra Stati: l’Irlanda deve farsi restituire 13 miliardi di agevolazioni concesse ad Apple, oltre a 2,4 miliardi di multa per Google, per ordine della Corte di giustizia. Altro che licenze dei balneari! Sul fisco, sui migranti, su Ucraina e Cina, sull’energia è una disunione europea tutta «green e distintivo». Chissà se un Whatever it takes «bis», a scoppio ritardato, la cambierà.
Una strategia che prescrive all’Unione una profonda revisione di scelte e della propria identità per non essere esclusi dal futuro globale. L’ha tratteggiata Mario Draghi, ovvero colui che queste istituzioni le ha comunque costruite…È la sindrome Bocca di rosa, dalla canzone di Fabrizio De André: si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Ha colpito pure Mario Draghi, che si fa censore del declino europeo avendo assai contribuito alla costruzione di quest’Europa a partire dal 1992 quando organizzò sul Royal Yacht «Britannia» la svendita delle industrie di Stato per inseguire il diktat della triade Andreatta-Carli-Ciampi, la quale invocava il vincolo esterno per un’Italia riottosa alle regole. Avverte l’ex presidente della Banca centrale europea che il continente o cambia in fretta, risolve i problemi dell’energia, fa debito comune, si arma e torna protagonista nella ricerca e nella diplomazia, o si sfalderà. I numeri messi in fila da Draghi sono impressionanti; 800 miliardi di euro all’anno d’investimenti pari al 4,7 per cento del Pil dei 27 per cogliere tre obiettivi: cercare di colmare il gap con Stati Uniti e Cina, decarbonizzare, difendersi. I soldi si trovano dal debito comune e dalle tasche degli europei tenendo presente che da qui al 2040 si perderanno in Europa due milioni di lavoratori all’anno. Dunque: aumentiamo l’immigrazione.La forbice tra il Pil Usa e quello della Ue si è allargata dal 15 per cento d’inizio secolo al 30 per cento dello scorso anno e il reddito pro capite oltre Atlantico oggi è il doppio di quello europeo. Però a parlar male di Bruxelles si fa peccato. Lo ha ricordato Sergio Mattarella al recente Forum Ambrosetti di Cernobbio; deve aver avuto in anteprima il dossier di Draghi. Ha detto il presidente della Repubblica: l’Italia deve ridurre il debito, ma questo non è il solo parametro, l’Europa è incompleta, ma guai a sollevare dei distinguo. Le risposte che nei fatti Draghi ha incassato vanno però in direzione ostinata e contraria: il suo studio è destinato a finire in un cassetto. Ursula von der Leyen che rinvia la presentazione della sua nuova Commissione. Ci sono tensioni: difficile che una maggioranza composta da Ppe, Socialisti, Verdi e Liberali passi indenne dal Parlamento, dove i veri vincitori sono le formazioni di destra. Il caso Raffaele Fitto, il nostro ministro agli Affari europei indicato da Giorgia Meloni come prossimo commissario e vicepresidente esecutivo con delega all’Economia e al Pnrr, agita i sonni della Von der Leyen. La baronessa intende proporlo, mentre Renew, ciò che resta di Emmanuel Macron, Socialisti e Verdi non vogliono sentirne parlare. Al punto che il Pd sta studiando il da farsi, ma la segretaria Elly Schlein boccerebbe Fitto molto volentieri. Ci sono i tedeschi con l’economia in panne e preoccupatissimi per l’avanzata dei sovranisti di destra (Afd) e di sinistra, i quali non vogliono fare debito comune, ma soprattutto sono stanchi di guerra in Ucraina. Hanno di nuovo bisogno del gas russo, tentennano sull’aiuto a Volodymyr Zelensky, si mettono di traverso sui dazi alla Cina. Il cancelliere Scholz chiude le frontiere per bloccare i migranti, Viktor Orbán addirittura vuole spedire chi arriva in Ungheria direttamente a Bruxelles e chiede di trattare con Mosca. Su economia, migranti, politica estera viene da chiedersi: se questa è Europa… Si parla molto del debito italiano, pochissimi però ricordano che si è accumulato per pagare la spesa per interessi a partire dalla lettera del 12 febbraio 1981 quando Carlo Azeglio Ciampi, allora governatore della Banca d’Italia, e Beniamino Andretta ministro del Tesoro decisero il divorzio tra palazzo Koch e via XX Settembre. Tra il 1980 e il 1994 il debito crebbe dal 57,7 per cento sul Pil nel 1980 al 124,3 nel ’94; la spesa per interessi passò dall’8 per cento del Pil nel 1984 all’11,4 dieci anni dopo, la maggiore d’Europa con una punta nel 1993 del 13 per cento a petto del 4,4 in quella che si apprestava a essere la zona euro. Fu allora che Mario Draghi lanciò l’idea di svendere per inseguire l’euro. Il secondo enorme stock si è sostanziato con l’entrata in vigore dell’euro e le regole di Maastricht. Quelle che la scorsa settimana Draghi ha criticato presentando il suo rapporto sulla competitività che è già lettera morta e nulla ha di rivoluzionario. È l’espansione in circa 400 pagine di un articolo che aveva scritto per il quotidiano Financial Times nell’aprile del 2020 esortando l’Ue a fare qualcosa perché l’economia congelata dal Covid riprendesse. Anche da quell’esortazione scaturì il Next Generation Ue che oggi traduciamo in Pnrr, che non è debito comune: va ripagato! Draghi ha riproposto quello schema con toni ancora più severi. O l’Europa cresce o si avvia a un’agonia. L’ex presidente del Consiglio vuole un «piano Marshall» – doppio nelle proporzioni rispetto all’originale – da investire in tecnologia, difesa, recupero di produttività, sostenibilità. Per farlo serve debito comune e attaccare il risparmio privato: 1.200 miliardi di euro all’anno. È perciò necessaria una riforma radicale in Europa: basta decisioni all’unanimità e in sottofondo (è da sempre un tratto distintivo del Draghi-pensiero) basta anche con questo eccesso di autodeterminazione: gli Stati devono cedere sovranità alla struttura tecnocratica di una Commissione che deve essere riformata e rafforzata. Queste le parole di Draghi: «Se non vogliono continuare ad arretrare in un contesto internazionale in rapida evoluzione, la Ue e i suoi Stati membri devono agire e smetterla di procrastinare, di rinviare le decisioni che devono essere prese, nell’illusione di preservare il consenso degli elettori. La Ue deve agire per riformarsi, se non vuole spegnersi in una lenta agonia».Ovviamente le scelte per l’ambiente sono indiscutibili e il tema centrale è: meno regole e più soldi. Uno studio dell’Università del Nevada ha messo a confronto la strategia green di Ue e Usa ed è arrivato a questa conclusione: l’Europa ha fatto solo regolamenti, gli Stati Uniti cinque norme e 730 miliardi di dollari d’investimenti. Nel rapporto sulla competitività chiesto dalla Von der Leyen, Draghi ha tentato una riedizione del suo imperativo Whatever it takes, ma non gli è andata benissimo. Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha replicato a stretto giro: «Il prestito congiunto dell’Ue non risolverà alcun problema strutturale. Più debito pubblico costa interessi, ma non crea necessariamente più crescita». Già: quando era alla Bce, Draghi non suscitava entusiasmi in Germania e in tedesco «debito» e «colpa» suona assai simile: schuld/schulden… Dalla Francia arriva un’apertura, ma la rampogna dell’ex presidente della Bce è durata lo spazio di un mattino. L’Europa non è in grado di emendarsi perché non ha mai completato la sua unione e il «censore» dovrebbe meditare sul detto latino: medice, cura te ipsum. Perché Draghi che invoca debito comune – come peraltro fa Piero Cipollone, membro italiano del board della Bce convinto che un titolo garantito dall’Ue vada a ruba e abbia la «tripla A» – è la stessa persona che il 5 agosto 2011, entrando in Bce, firmò con Jean-Claude Trichet la lettera di sfratto a Silvio Berlusconi mentre Giulio Tremonti, ministro dell’Economia, invocava gli Eurobond. Difese l’impatto rigorista dei governi tecnici e senza consenso che ha portato il debito/Pil dal 126 per cento con Mario Monti al 149 per cento con lo stesso Draghi. Oggi il nuovo patto di stabilità è ancora la camicia di forza.La Germania – produzione industriale crollata del 2,4 per cento – non intende fare sconti. Lo sa anche l’attuale presidedente Bce Christine Lagarde che deve tagliare i tassi a tappe forzate per far marciare l’economia, soprattutto se lo farà anche la Federal reserve americana. Ma lo fa con un primo timido passo (-0,25). E infatti Isabel Schnabel – è la «badante» della Lagarde in Bce per conto della Bundesbank – fa sapere: piano con i tagli. Anni fa – plaudente Draghi – Angela Merkel proclamò: ciò che è buono per la Germania lo è per l’Europa. Ora la Francia con Michel Barnier, appena imposto da Macron quale premier, non sa come fare la sua finanziaria. Gli è esploso il debito (oltre il 100 per cento del Pil), ha i redditi in caduta, la produzione giù di mezzo punto. L’Europa in preda a due debolezze è la stessa del dumping fiscale fra Stati: l’Irlanda deve farsi restituire 13 miliardi di agevolazioni concesse ad Apple, oltre a 2,4 miliardi di multa per Google, per ordine della Corte di giustizia. Altro che licenze dei balneari! Sul fisco, sui migranti, su Ucraina e Cina, sull’energia è una disunione europea tutta «green e distintivo». Chissà se un Whatever it takes «bis», a scoppio ritardato, la cambierà.
Una strategia che prescrive all’Unione una profonda revisione di scelte e della propria identità per non essere esclusi dal futuro globale. L’ha tratteggiata Mario Draghi, ovvero colui che queste istituzioni le ha comunque costruite…
È la sindrome Bocca di rosa, dalla canzone di Fabrizio De André: si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Ha colpito pure Mario Draghi, che si fa censore del declino europeo avendo assai contribuito alla costruzione di quest’Europa a partire dal 1992 quando organizzò sul Royal Yacht «Britannia» la svendita delle industrie di Stato per inseguire il diktat della triade Andreatta-Carli-Ciampi, la quale invocava il vincolo esterno per un’Italia riottosa alle regole. Avverte l’ex presidente della Banca centrale europea che il continente o cambia in fretta, risolve i problemi dell’energia, fa debito comune, si arma e torna protagonista nella ricerca e nella diplomazia, o si sfalderà. I numeri messi in fila da Draghi sono impressionanti; 800 miliardi di euro all’anno d’investimenti pari al 4,7 per cento del Pil dei 27 per cogliere tre obiettivi: cercare di colmare il gap con Stati Uniti e Cina, decarbonizzare, difendersi. I soldi si trovano dal debito comune e dalle tasche degli europei tenendo presente che da qui al 2040 si perderanno in Europa due milioni di lavoratori all’anno. Dunque: aumentiamo l’immigrazione.
La forbice tra il Pil Usa e quello della Ue si è allargata dal 15 per cento d’inizio secolo al 30 per cento dello scorso anno e il reddito pro capite oltre Atlantico oggi è il doppio di quello europeo. Però a parlar male di Bruxelles si fa peccato. Lo ha ricordato Sergio Mattarella al recente Forum Ambrosetti di Cernobbio; deve aver avuto in anteprima il dossier di Draghi. Ha detto il presidente della Repubblica: l’Italia deve ridurre il debito, ma questo non è il solo parametro, l’Europa è incompleta, ma guai a sollevare dei distinguo. Le risposte che nei fatti Draghi ha incassato vanno però in direzione ostinata e contraria: il suo studio è destinato a finire in un cassetto. Ursula von der Leyen che rinvia la presentazione della sua nuova Commissione. Ci sono tensioni: difficile che una maggioranza composta da Ppe, Socialisti, Verdi e Liberali passi indenne dal Parlamento, dove i veri vincitori sono le formazioni di destra. Il caso Raffaele Fitto, il nostro ministro agli Affari europei indicato da Giorgia Meloni come prossimo commissario e vicepresidente esecutivo con delega all’Economia e al Pnrr, agita i sonni della Von der Leyen. La baronessa intende proporlo, mentre Renew, ciò che resta di Emmanuel Macron, Socialisti e Verdi non vogliono sentirne parlare. Al punto che il Pd sta studiando il da farsi, ma la segretaria Elly Schlein boccerebbe Fitto molto volentieri.
Ci sono i tedeschi con l’economia in panne e preoccupatissimi per l’avanzata dei sovranisti di destra (Afd) e di sinistra, i quali non vogliono fare debito comune, ma soprattutto sono stanchi di guerra in Ucraina. Hanno di nuovo bisogno del gas russo, tentennano sull’aiuto a Volodymyr Zelensky, si mettono di traverso sui dazi alla Cina. Il cancelliere Scholz chiude le frontiere per bloccare i migranti, Viktor Orbán addirittura vuole spedire chi arriva in Ungheria direttamente a Bruxelles e chiede di trattare con Mosca. Su economia, migranti, politica estera viene da chiedersi: se questa è Europa… Si parla molto del debito italiano, pochissimi però ricordano che si è accumulato per pagare la spesa per interessi a partire dalla lettera del 12 febbraio 1981 quando Carlo Azeglio Ciampi, allora governatore della Banca d’Italia, e Beniamino Andretta ministro del Tesoro decisero il divorzio tra palazzo Koch e via XX Settembre. Tra il 1980 e il 1994 il debito crebbe dal 57,7 per cento sul Pil nel 1980 al 124,3 nel ’94; la spesa per interessi passò dall’8 per cento del Pil nel 1984 all’11,4 dieci anni dopo, la maggiore d’Europa con una punta nel 1993 del 13 per cento a petto del 4,4 in quella che si apprestava a essere la zona euro. Fu allora che Mario Draghi lanciò l’idea di svendere per inseguire l’euro. Il secondo enorme stock si è sostanziato con l’entrata in vigore dell’euro e le regole di Maastricht. Quelle che la scorsa settimana Draghi ha criticato presentando il suo rapporto sulla competitività che è già lettera morta e nulla ha di rivoluzionario. È l’espansione in circa 400 pagine di un articolo che aveva scritto per il quotidiano Financial Times nell’aprile del 2020 esortando l’Ue a fare qualcosa perché l’economia congelata dal Covid riprendesse. Anche da quell’esortazione scaturì il Next Generation Ue che oggi traduciamo in Pnrr, che non è debito comune: va ripagato! Draghi ha riproposto quello schema con toni ancora più severi. O l’Europa cresce o si avvia a un’agonia.
L’ex presidente del Consiglio vuole un «piano Marshall» – doppio nelle proporzioni rispetto all’originale – da investire in tecnologia, difesa, recupero di produttività, sostenibilità. Per farlo serve debito comune e attaccare il risparmio privato: 1.200 miliardi di euro all’anno. È perciò necessaria una riforma radicale in Europa: basta decisioni all’unanimità e in sottofondo (è da sempre un tratto distintivo del Draghi-pensiero) basta anche con questo eccesso di autodeterminazione: gli Stati devono cedere sovranità alla struttura tecnocratica di una Commissione che deve essere riformata e rafforzata. Queste le parole di Draghi: «Se non vogliono continuare ad arretrare in un contesto internazionale in rapida evoluzione, la Ue e i suoi Stati membri devono agire e smetterla di procrastinare, di rinviare le decisioni che devono essere prese, nell’illusione di preservare il consenso degli elettori. La Ue deve agire per riformarsi, se non vuole spegnersi in una lenta agonia».
Ovviamente le scelte per l’ambiente sono indiscutibili e il tema centrale è: meno regole e più soldi. Uno studio dell’Università del Nevada ha messo a confronto la strategia green di Ue e Usa ed è arrivato a questa conclusione: l’Europa ha fatto solo regolamenti, gli Stati Uniti cinque norme e 730 miliardi di dollari d’investimenti. Nel rapporto sulla competitività chiesto dalla Von der Leyen, Draghi ha tentato una riedizione del suo imperativo Whatever it takes, ma non gli è andata benissimo. Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha replicato a stretto giro: «Il prestito congiunto dell’Ue non risolverà alcun problema strutturale. Più debito pubblico costa interessi, ma non crea necessariamente più crescita». Già: quando era alla Bce, Draghi non suscitava entusiasmi in Germania e in tedesco «debito» e «colpa» suona assai simile: schuld/schulden… Dalla Francia arriva un’apertura, ma la rampogna dell’ex presidente della Bce è durata lo spazio di un mattino. L’Europa non è in grado di emendarsi perché non ha mai completato la sua unione e il «censore» dovrebbe meditare sul detto latino: medice, cura te ipsum. Perché Draghi che invoca debito comune – come peraltro fa Piero Cipollone, membro italiano del board della Bce convinto che un titolo garantito dall’Ue vada a ruba e abbia la «tripla A» – è la stessa persona che il 5 agosto 2011, entrando in Bce, firmò con Jean-Claude Trichet la lettera di sfratto a Silvio Berlusconi mentre Giulio Tremonti, ministro dell’Economia, invocava gli Eurobond. Difese l’impatto rigorista dei governi tecnici e senza consenso che ha portato il debito/Pil dal 126 per cento con Mario Monti al 149 per cento con lo stesso Draghi. Oggi il nuovo patto di stabilità è ancora la camicia di forza.
La Germania – produzione industriale crollata del 2,4 per cento – non intende fare sconti. Lo sa anche l’attuale presidedente Bce Christine Lagarde che deve tagliare i tassi a tappe forzate per far marciare l’economia, soprattutto se lo farà anche la Federal reserve americana. Ma lo fa con un primo timido passo (-0,25). E infatti Isabel Schnabel – è la «badante» della Lagarde in Bce per conto della Bundesbank – fa sapere: piano con i tagli. Anni fa – plaudente Draghi – Angela Merkel proclamò: ciò che è buono per la Germania lo è per l’Europa. Ora la Francia con Michel Barnier, appena imposto da Macron quale premier, non sa come fare la sua finanziaria. Gli è esploso il debito (oltre il 100 per cento del Pil), ha i redditi in caduta, la produzione giù di mezzo punto. L’Europa in preda a due debolezze è la stessa del dumping fiscale fra Stati: l’Irlanda deve farsi restituire 13 miliardi di agevolazioni concesse ad Apple, oltre a 2,4 miliardi di multa per Google, per ordine della Corte di giustizia. Altro che licenze dei balneari! Sul fisco, sui migranti, su Ucraina e Cina, sull’energia è una disunione europea tutta «green e distintivo». Chissà se un Whatever it takes «bis», a scoppio ritardato, la cambierà.