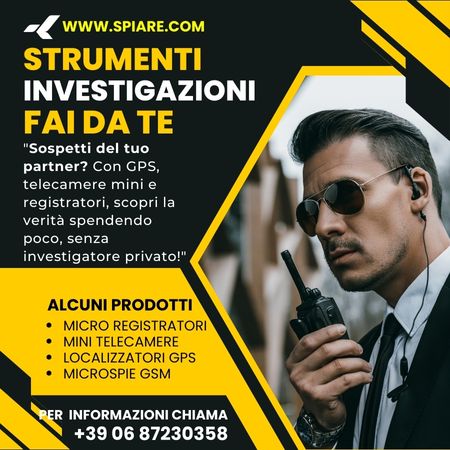Contenuto
- 1 Perché è Nata la Bandiera Italiana e Il Vessillo di una Nazione – Un Documento Storico Tessuto di Speranze e Battaglie
- 2 I. L’Italia Policroma: Un Mosaico di Stati e Stendardi Prima del 1796
- 3 II. Perché è Nata la Bandiera Italiana e La Scintilla Napoleonica: L’Importazione degli Ideali e del Modello Tricolore
- 4 III. Perché è Nata la Bandiera Italiana, La Genesi Militare e Civica del Vessillo: Da Milano all’Emilia
- 5 IV. Perché è Nata la Bandiera Italiana e L’Atto di Nascita Ufficiale: Reggio Emilia, 7 Gennaio 1797
- 6 V. Perché è Nata la Bandiera Italiana. Un Simbolo Clandestino e Rivoluzionario: Il Tricolore nel Risorgimento (1814-1848)
- 7 VI. Perché è Nata la Bandiera Italiana e La Consacrazione Istituzionale: Dallo Statuto Albertino al Regno d’Italia (1848-1946)
- 8 VII. Perché è Nata la Bandiera Italiana e della Repubblica: L’Articolo 12 della Costituzione
- 9 VIII. Analisi dei Colori: Tra Storia, Simbolismo e Mito
- 10 Conclusione
Perché è Nata la Bandiera Italiana e Il Vessillo di una Nazione – Un Documento Storico Tessuto di Speranze e Battaglie
Perché è nata la bandiera italiana? La bandiera italiana, il Tricolore, è molto più di un semplice drappo di tessuto. È un documento storico, un simbolo vivente che narra la complessa e spesso tumultuosa genesi della nazione italiana. La sua storia non è quella di un oggetto statico, ma di un’idea in perenne evoluzione, un vessillo che ha incarnato le speranze di generazioni, dalle prime influenze straniere e i nascenti fervori patriottici, attraverso le battaglie rivoluzionarie e la cooptazione monarchica, fino alla sua consacrazione finale come emblema della Repubblica. Il racconto della sua nascita è il racconto della formazione dell’Italia stessa. Fin dalla sua origine, il Tricolore ha dimostrato una straordinaria capacità di unire, fungendo da catalizzatore per le aspirazioni di un popolo frammentato, un ruolo che ha mantenuto intatto dai campi di battaglia del Risorgimento fino alle crisi contemporanee, dove è riapparso sui balconi come simbolo di resilienza e identità condivisa. La sua genesi si colloca in un punto di incontro cruciale tra il pragmatismo militare e l’ideologia rivoluzionaria, ma il suo significato più profondo, quello di simbolo nazionale, è stato un’acquisizione successiva, conquistata con il sangue e il sacrificio.
Tabella 1: Perché è Nata la Bandiera Italiana e l’Evoluzione Cronologica del Tricolore Italiano
| Periodo | Evento Chiave | Forma del Vessillo | Status Giuridico |
| 1796-1797 | Formazione della Legione Lombarda e della Legione Italiana | Stendardo militare a tre bande verticali (verde, bianco, rosso) | Vessillo militare |
| 1797-1814 | Proclamazione della Repubblica Cispadana e successive repubbliche napoleoniche | Bande orizzontali (rosso, bianco, verde) con emblema centrale (es. turcasso) | Bandiera di Stato (Repubblica Cispadana) |
| 1814-1848 | Restaurazione e moti carbonari/mazziniani | Bande verticali, senza emblemi | Simbolo rivoluzionario e clandestino |
| 1848-1861 | Adozione da parte di Carlo Alberto e Prima Guerra d’Indipendenza | Bande verticali con stemma sabaudo (croce bianca su scudo rosso bordato d’azzurro) al centro | Bandiera del Regno di Sardegna |
| 1861-1946 | Proclamazione del Regno d’Italia | Bande verticali con stemma sabaudo coronato al centro | Bandiera del Regno d’Italia |
| 1946-Presente | Proclamazione della Repubblica Italiana | Bande verticali di eguali dimensioni, senza emblemi | Bandiera della Repubblica (Art. 12 Costituzione) |
I. L’Italia Policroma: Un Mosaico di Stati e Stendardi Prima del 1796
Per comprendere l’impatto rivoluzionario dell’introduzione del Tricolore, è fondamentale visualizzare la penisola italiana della fine del XVIII secolo: non una nazione, ma, come la definì il cancelliere austriaco Metternich, una mera “espressione geografica”. L’Italia era un mosaico di regni, ducati, repubbliche aristocratiche e domini papali, ognuno con la propria identità, le proprie leggi e, soprattutto, la propria bandiera. Questa frammentazione politica si rifletteva in una variegata panoplia di stendardi che sottolineavano le divisioni piuttosto che un’identità comune.
Il Regno di Sardegna sventolava la croce bianca in campo rosso della dinastia Savoia; gli Estensi a Modena usavano un’aquila bianca in campo azzurro; il Regno di Napoli e la Sicilia avevano i loro complessi stemmi borbonici; lo Stato Pontificio utilizzava diverse insegne, tra cui il rosso e il giallo. Questi vessilli non rappresentavano un “popolo” nel senso moderno del termine, ma erano simboli dinastici o militari, espressione del potere di un sovrano o dell’autorità di una città-stato. La bandiera era un’insegna di comando, non un emblema di appartenenza nazionale.
Questa situazione creò quello che può essere definito un “vuoto vessillologico”. L’assenza di un simbolo pan-italiano preesistente non fu una semplice mancanza, ma rappresentò un’opportunità cruciale. Quando gli ideali della Rivoluzione Francese, che portavano con sé il concetto di una bandiera nazionale come espressione della sovranità popolare, attraversarono le Alpi, non trovarono un simbolo consolidato con cui competere. Il Tricolore poté quindi essere introdotto non come sostituto di un vecchio emblema, ma come il primo e inedito simbolo di una nuova idea politica per l’intera penisola. La sua novità fu la sua più grande forza, rendendolo un emblema potente e incontaminato per coloro che aspiravano a una radicale trasformazione politica e sociale.
II. Perché è Nata la Bandiera Italiana e La Scintilla Napoleonica: L’Importazione degli Ideali e del Modello Tricolore
La nascita della bandiera italiana è indissolubilmente legata alla discesa in Italia del generale Napoleone Bonaparte nel 1796. La sua campagna non fu solo una conquista militare, ma anche un’invasione ideologica che portò con sé i principi di libertà, uguaglianza e nazione che avevano infiammato la Rivoluzione Francese. Il Tricolore francese, con le sue tre bande verticali, era diventato l’archetipo della bandiera nazionale moderna, un simbolo di rottura con l’Ancien Régime che ispirò movimenti rivoluzionari in tutta Europa.
In Italia, questi ideali trovarono terreno fertile tra i cosiddetti “giacobini” italiani, patrioti e intellettuali che vedevano in Napoleone un liberatore, l’uomo che avrebbe potuto porre fine a secoli di frammentazione politica, arretratezza sociale e dominazione straniera. Furono questi gruppi i primi ad adottare simboli ispirati al modello francese. Prima ancora delle bandiere, i colori verde, bianco e rosso fecero la loro comparsa sulle coccarde, distintivi circolari appuntati sugli abiti. Sebbene alcune fonti menzionino un’apparizione a Genova già nel 1789, la loro diffusione è documentata con certezza a Bologna e Milano nel 1796, come segno di adesione ai nuovi ideali rivoluzionari.
La genesi del Tricolore avvenne all’interno di una relazione che, sebbene simbiotica, era fondamentalmente asimmetrica. I patrioti italiani avevano bisogno della potenza militare di Napoleone per rovesciare i vecchi regimi e realizzare le loro aspirazioni unitarie. D’altro canto, Napoleone necessitava di alleati locali per legittimare il suo controllo, amministrare i territori conquistati e reclutare truppe per le sue armate. Le “Repubbliche Sorelle” che sorsero in quel periodo, come la Cispadana e la Cisalpina, erano di fatto stati satellite della Francia. La bandiera nacque quindi in questo complesso nesso di autentica aspirazione patriottica e calcolo geopolitico. Era il simbolo delle speranze italiane, ma la sua esistenza dipendeva dalla supremazia militare e politica francese. Questa dipendenza spiega perché il Tricolore fu abolito con la caduta di Napoleone, per poi riemergere più tardi come simbolo puramente indigeno di ribellione.
III. Perché è Nata la Bandiera Italiana, La Genesi Militare e Civica del Vessillo: Da Milano all’Emilia
A differenza di quanto si possa pensare, l’origine dei colori della bandiera italiana non affonda le radici in un astratto simbolismo, ma in una concreta realtà storica, militare e civica, legata principalmente alla città di Milano.
- Il Bianco e il Rosso di Milano: Due dei tre colori, il bianco e il rosso, hanno una profonda radice storica. Essi erano i colori dell’antichissimo stemma comunale di Milano, una croce rossa su campo bianco, un simbolo che risaliva all’epoca dei comuni medievali.
- Il Verde della Guardia Civica Milanese: Il terzo colore, il verde, quello che sostituì l’azzurro del tricolore francese, ha un’origine prettamente militare. Era infatti il colore delle uniformi della Guardia Civica Milanese, una milizia cittadina le cui divise erano verdi fin dal 1782 e che fu riorganizzata dopo l’arrivo delle truppe francesi.
La fusione di questi tre colori in un unico stendardo avvenne per la prima volta in un contesto militare. L’11 ottobre 1796, la Legione Lombarda, un corpo di volontari formatosi per affiancare l’esercito di Napoleone, adottò un vessillo di guerra con i colori verde, bianco e rosso. Un documento dell’epoca attesta che fu lo stesso Napoleone ad approvare la scelta di questi colori come “nazionali” per i patrioti milanesi, con la frase: “les couleurs nationales qu’ils ont adopté sont le vert, le blanc et le rouge“. Questo evento segna la nascita del Tricolore come stendardo militare.
Poco dopo, gli stessi colori furono adottati anche dalla Legione Italiana, un’unità che raccoglieva soldati provenienti dalle terre dell’Emilia e della Romagna. Questa rapida diffusione del vessillo dalla Lombardia all’Emilia fu il passo decisivo che precedette la sua adozione ufficiale da parte di un’entità statale.
Questo processo rivela un aspetto fondamentale: il Tricolore non nacque da un’insurrezione popolare spontanea, ma fu in primo luogo uno strumento di costruzione statale imposto dall’alto, attraverso l’esercito. Mettendo soldati provenienti da Milano, Bologna, Ferrara e Modena sotto un’unica bandiera, si perseguiva uno scopo pratico: creare un’identità coesa per un nuovo esercito, indispensabile per il consolidamento delle nuove repubbliche. Si trattò di un atto di “costruzione della nazione attraverso l’uniforme”. Prima di rappresentare il “popolo” italiano, la bandiera rappresentò il soldato italiano del nuovo ordine. Questa origine militare le conferì un’indelebile associazione con la lotta, il sacrificio e l’onore marziale, temi che sarebbero risuonati con forza per tutto il Risorgimento.
IV. Perché è Nata la Bandiera Italiana e L’Atto di Nascita Ufficiale: Reggio Emilia, 7 Gennaio 1797
Il momento in cui il Tricolore passò dall’essere un vessillo militare a bandiera ufficiale di uno Stato sovrano è precisamente documentato. Avvenne a Reggio Emilia, il 7 gennaio 1797. In seguito alle vittorie napoleoniche, i delegati delle città di Reggio, Modena, Bologna e Ferrara si riunirono in un congresso per dare vita a una nuova entità statale, la Repubblica Cispadana.
Durante la XIV sessione del congresso, tenutasi in una sala del municipio oggi nota come “Sala del Tricolore”, il deputato e giurista Giuseppe Compagnoni, ricordato per questo come il “Padre del Tricolore”, avanzò la mozione formale per l’adozione di una bandiera nazionale. La sua proposta fu accolta con entusiasmo e approvata dall’assemblea, che emanò un decreto storico:
“che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso, e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti“.
Questo decreto segna l’atto di nascita legale e ufficiale della bandiera italiana. In riconoscimento di questo evento, il 7 gennaio è stato dichiarato “Festa del Tricolore”.
Il primo disegno della bandiera cispadana differiva da quello attuale. Presentava le tre bande disposte orizzontalmente, con il rosso in alto, il bianco al centro e il verde in basso. Al centro della fascia bianca era posto un emblema: un turcasso (una faretra) contenente quattro frecce, a simboleggiare l’unione delle quattro città fondatrici, circondato da un serto d’alloro. Questo disegno iniziale evidenzia come la bandiera fosse, in origine, il simbolo di una specifica repubblica regionale e non ancora dell’intera “Italia”.
L’evento del 7 gennaio 1797 fu un atto politico e giuridico di fondamentale importanza. Trasformò il Tricolore da emblema militare de facto a simbolo de jure di un’entità politica sovrana. Il dibattito e il decreto formale rappresentano il momento in cui la bandiera acquisì una legittimità istituzionale. Fu un atto consapevole di state-building, che utilizzò i meccanismi formali di un’assemblea parlamentare per dichiarare un’identità collettiva. Questo stabilì un precedente cruciale: la legittimità della bandiera sarebbe stata da allora legata a un’adozione formale e statale, un principio che sarebbe stato seguito dal Regno di Sardegna nel 1848 e, infine, dalla Repubblica Italiana nel 1946.
V. Perché è Nata la Bandiera Italiana. Un Simbolo Clandestino e Rivoluzionario: Il Tricolore nel Risorgimento (1814-1848)
Con la caduta di Napoleone e il Congresso di Vienna (1814-15), l’ordine politico in Italia fu restaurato. Le repubbliche napoleoniche furono smantellate, i vecchi sovrani tornarono sui loro troni e il Tricolore fu ufficialmente abolito. Tuttavia, la bandiera non fu dimenticata. Anzi, la sua proscrizione la trasformò in un potente simbolo di resistenza. Sopravvisse nella clandestinità, diventando l’emblema della lotta contro le monarchie assolute restaurate e contro la dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto.
Il Tricolore riapparve con forza durante i moti rivoluzionari del 1820-21 e del 1831, sventolando nelle insurrezioni guidate dalle società segrete come la Carboneria in Piemonte, nelle Legazioni Pontificie e nel Regno delle Due Sicilie. La sua associazione con la ribellione e la richiesta di libertà e costituzioni si consolidò in questi decenni.
Una svolta ideologica cruciale avvenne nel 1831, quando Giuseppe Mazzini scelse esplicitamente il Tricolore come vessillo della Giovine Italia, il movimento da lui fondato per promuovere un’Italia unita, indipendente e repubblicana. Mazzini ne caricò il significato, associandolo al suo programma politico: “I colori della Giovine Italia sono: il bianco, il rosso e il verde. La bandiera della Giovine Italia porta su quei colori, scritte da un lato le parole: Libertà, Uguaglianza, Indipendenza“.
In questi anni, la bandiera trascende la sfera puramente politica per entrare nell’immaginario culturale e romantico del Risorgimento. Nel 1847, il giovane Goffredo Mameli, nel suo “Canto degli Italiani” (destinato a diventare l’inno nazionale), ne consacrò il valore poetico con il celebre verso: “Raccolgaci un’unica bandiera, una speme“.
La potenza simbolica del Tricolore fu paradossalmente amplificata dalla sua soppressione ufficiale. Essendo bandito dai regimi della Restaurazione, il suo possesso o la sua esposizione divennero atti di aperta sfida, punibili con il carcere o l’esilio. Questa proibizione, che mirava a cancellarne la memoria, ottenne l’effetto opposto: ammantò la bandiera di un’aura di verità proibita e di eroismo romantico. Costretta alla clandestinità, si spogliò della sua originaria associazione con le repubbliche dominate dai francesi e rinacque come simbolo puramente italiano di dissenso. Ogni volta che veniva cucita in segreto o innalzata con sprezzo del pericolo su una barricata, il suo significato si approfondiva. Non rappresentava più uno Stato che era esistito, ma una nazione che doveva esistere. La sua assenza dai palazzi del potere rendeva la sua presenza nei cuori dei patrioti ancora più forte e vibrante.
VI. Perché è Nata la Bandiera Italiana e La Consacrazione Istituzionale: Dallo Statuto Albertino al Regno d’Italia (1848-1946)
Il 1848, l’anno della “Primavera dei Popoli”, segnò una svolta decisiva per il Tricolore. Durante l’ondata di rivoluzioni che scosse l’Europa, la bandiera verde, bianca e rossa divenne il simbolo universale del movimento per l’indipendenza italiana. Sventolò sulle barricate delle Cinque Giornate di Milano, fu innalzata dalla risorta Repubblica di San Marco a Venezia e divenne l’emblema della Repubblica Romana, unendo patrioti di ogni tendenza politica.
In questo contesto, il Re di Sardegna-Piemonte, Carlo Alberto di Savoia, compì un gesto di straordinaria abilità politica. Il 23 marzo 1848, alla vigilia dell’intervento militare contro l’Austria che diede inizio alla Prima Guerra d’Indipendenza, decise di adottare il Tricolore come bandiera del suo esercito e del suo regno. Nel suo proclama, annunciò che le sue truppe avrebbero portato “lo Scudo di Savoia sovrapposto alla Bandiera tricolore italiana“. Lo stemma sabaudo, una croce bianca su scudo rosso, fu inserito nella banda bianca centrale. Successivamente, allo scudo fu aggiunta una bordatura azzurra per evitare che il bianco e il rosso dello stemma si confondessero con i colori della bandiera.
Questa decisione fu un capolavoro di cooptazione simbolica. Fino a quel momento, il Tricolore era stato fortemente associato agli ideali repubblicani di Mazzini. La Casa Savoia, invece, rappresentava una visione monarchica per il futuro dell’Italia. Sovrapponendo il proprio scudo dinastico al vessillo rivoluzionario, Carlo Alberto riuscì a fondere simbolicamente le due principali correnti del Risorgimento. Questo atto permise alla monarchia di incanalare l’immensa energia patriottica legata al Tricolore, neutralizzandone le connotazioni esclusivamente repubblicane. La bandiera divenne così un simbolo “ombrello”, accettabile sia per i monarchici sia per molti repubblicani disposti a sacrificare la forma di governo in nome dell’unità nazionale. Lo stemma sulla bandiera rappresentava visivamente il compromesso politico alla base dell’unificazione italiana: un movimento nazionale popolare guidato e infine controllato da una monarchia preesistente.
Con la proclamazione del Regno d’Italia, il 17 marzo 1861, questa versione del Tricolore con lo stemma sabaudo divenne la bandiera nazionale del nuovo Stato. Tuttavia, per decenni mancò una legge che ne codificasse in modo univoco le caratteristiche, portando alla produzione di vessilli con fogge e proporzioni diverse. Solo nel 1925 furono definiti per legge i modelli ufficiali della bandiera nazionale e della bandiera di Stato, quest’ultima con l’aggiunta della corona reale sopra lo stemma.
VII. Perché è Nata la Bandiera Italiana e della Repubblica: L’Articolo 12 della Costituzione
La storia della bandiera italiana giunse alla sua forma definitiva nel secondo dopoguerra. Dopo la caduta del regime fascista e la fine del conflitto, il 2 giugno 1946 il popolo italiano fu chiamato a un referendum istituzionale per scegliere tra monarchia e repubblica. La vittoria della repubblica segnò la fine del regno dei Savoia.
La conseguenza logica e immediata fu la rimozione dello stemma sabaudo dalla bandiera nazionale. Con un decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946, fu stabilita la foggia provvisoria della nuova bandiera, priva di qualsiasi simbolo dinastico. Si tornava così al “puro” Tricolore dei moti risorgimentali.
Il passo finale fu la sua consacrazione nella nuova carta fondamentale dello Stato. Il 24 marzo 1947, l’Assemblea Costituente, al termine di una discussione che si concluse con un applauso unanime e commosso, approvò la formula definitiva che sarebbe diventata l’articolo 12 della Costituzione. Entrata in vigore il 1° gennaio 1948, la Costituzione sancisce con chiarezza e semplicità:
“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni“.
Questo articolo conferì alla bandiera il suo status giuridico definitivo e immutabile come simbolo supremo della Repubblica Italiana democratica. In seguito, decreti governativi hanno specificato le esatte tonalità cromatiche dei colori (Verde felce, Bianco brillante, Rosso scarlatto secondo la classificazione Pantone) per garantirne l’uniformità.
La rimozione dello stemma sabaudo fu molto più di un semplice adeguamento alla nuova forma di governo. Fu un profondo atto di purificazione simbolica. Recideva il legame della bandiera non solo con gli 85 anni di monarchia, ma anche, e soprattutto, con il ventennio fascista, che aveva operato sotto l’insegna reale, tentando di sovrapporre la propria ideologia ai simboli della patria. Durante la Lotta di Liberazione, molti partigiani di diverse fazioni politiche avevano combattuto contro il nazifascismo proprio sotto il Tricolore “pulito”. Il ritorno alla bandiera delle origini rappresentò quindi un ritorno ai valori fondanti di libertà e sovranità popolare. La bandiera, come definita dall’articolo 12, divenne il simbolo di una nazione “riconsacrata dal sangue dei partigiani”, impegnata a costruire un futuro basato sui principi democratici della nuova Costituzione.
VIII. Analisi dei Colori: Tra Storia, Simbolismo e Mito
La potenza di un simbolo nazionale risiede anche nella sua capacità di caricarsi di significati che trascendono la sua origine storica. È il caso dei colori del Tricolore, per i quali si sono stratificate nel tempo diverse interpretazioni, che convivono con la documentazione storica.
Perché è Nata la Bandiera Italiana e l’Origine Storica: Come analizzato, la genesi dei colori è pragmatica e localizzata. Il verde deriva dalle uniformi della Guardia Civica Milanese, mentre il bianco e il rosso sono i colori dello stemma di Milano. Questa è la spiegazione storicamente accertata, legata a un contesto militare e civico specifico della fine del Settecento.
Le Interpretazioni Simboliche: Con il diffondersi del Tricolore come bandiera della causa nazionale durante il Risorgimento, emersero interpretazioni più poetiche e universali, che cercavano di infondere nei colori un significato più profondo e legato all’identità italiana:
- Verde: La speranza di un’Italia unita e libera, o il verde delle sue pianure e dei suoi prati.
- Bianco: La fede nella giusta causa dell’indipendenza, o il bianco delle nevi perenni delle Alpi.
- Rosso: La carità e l’amore patriottico, ma soprattutto il sangue versato dai martiri e dai soldati per conquistare l’unità e la libertà.
Perché è Nata la Bandiera Italiana e l’Interpretazione Teologica: Un’altra lettura, di grande fascino culturale, collega i tre colori alle tre virtù teologali del Cristianesimo: il verde per la Speranza, il bianco per la Fede e il rosso per la Carità. Questo simbolismo ha un illustre precedente nella letteratura italiana: nella Divina Commedia di Dante Alighieri, Beatrice appare a Dante nel Paradiso Terrestre vestita proprio con questi tre colori (“sovra candido vel cinta d’uliva, / donna m’apparve, sotto verde manto / vestita di color di fiamma viva“), che rappresentano appunto le tre virtù.
Miti e Associazioni Culturali: Nel tempo si sono aggiunte altre associazioni, come il legame, storicamente infondato, con i colori della Pizza Margherita, creata in onore della Regina Margherita di Savoia, o il richiamo al corbezzolo, una pianta considerata simbolo patrio perché in autunno presenta contemporaneamente le foglie verdi, i fiori bianchi e le bacche rosse.
Questa evoluzione del significato rivela una verità fondamentale sui simboli nazionali. La loro forza non risiede unicamente nella loro origine storica, ma nella loro capacità di assorbire e riflettere l’immaginario collettivo di un popolo. Il passaggio dalla spiegazione legata all’uniforme milanese a quella delle virtù teologali non è una contraddizione, ma una crescita. Mostra come un simbolo, una volta creato, riceva la sua “anima” dalle generazioni successive. Le interpretazioni poetiche, pur non essendo storicamente “corrette” riguardo all’origine, sono culturalmente “vere”, perché esprimono ciò che la bandiera è arrivata a significare per le persone che sotto di essa hanno combattuto, sono morte e hanno infine costruito una nazione. Il significato del Tricolore è un composito stratificato di fatti storici e di miti nazionali duraturi.
Conclusione
Il viaggio della bandiera italiana è l’epopea di un simbolo che ha saputo incarnare le trasformazioni di un’intera nazione. Nata come stendardo militare di una legione napoleonica, forgiata nel fervore delle repubbliche giacobine, è diventata l’emblema clandestino della speranza durante la Restaurazione, per poi essere consacrata dal sangue dei martiri del Risorgimento. Ha rappresentato il compromesso tra monarchia e rivoluzione nell’Italia unita e, infine, si è purificata per diventare il simbolo costituzionale di una repubblica democratica.
Il Tricolore non è una reliquia statica del passato, ma un simbolo vivente la cui storia rispecchia le lotte dell’Italia per l’identità, l’unità e la libertà. La sua evoluzione, da vessillo regionale a emblema nazionale, dimostra la sua straordinaria capacità di adattarsi e di assorbire le aspirazioni e i valori del popolo italiano in ogni fase della sua storia. Oggi, come sancito dalla Costituzione, rappresenta l’unità nazionale, i principi democratici, l’impegno civile e la dignità della Repubblica. È il filo rosso, bianco e verde che collega i patrioti del 1796 ai cittadini dell’Italia contemporanea, un richiamo costante ai sacrifici compiuti e ai valori su cui si fonda la convivenza civile.